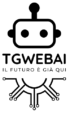Indice
- Il campanello d’allarme iberico
- Accuse di “kill switch” nel fotovoltaico cinese
- Dipendenza tecnologica e vulnerabilità geopolitica
- Allarme e diffidenza negli Stati Uniti
- Scenari futuri per l’Europa: indipendenza energetica e tecnologica
- La “via solare” italiana, tra orgoglio e vulnerabilità
Il campanello d’allarme iberico

Il 28 aprile 2025 la Penisola Iberica ha sperimentato il più vasto blackout europeo degli ultimi decenni: quasi 55 milioni di persone in Spagna e Portogallo sono rimaste al buio per oltre mezza giornata, con ricadute economiche stimate in centinaia di milioni di euro. Al momento del collasso, l’energia solare copriva il 53 % del mix elettrico e il vento un ulteriore 11 %; l’improvviso squilibrio di frequenza ha innescato le protezioni automatiche, facendo precipitare offline non solo le rinnovabili ma anche centrali a gas e nucleari — un effetto domino che il gestore REE sta ancora analizzando. Mentre il governo di Madrid e l’operatore di rete difendono l’affidabilità delle tecnologie verdi, gli scettici puntano il dito contro una rete poco interconnessa con il resto d’Europa e incapace di gestire picchi di generazione intermittente senza un’adeguata riserva di inerzia. L’incidente dimostra come l’energia del sole, se non accompagnata da infrastrutture digitali e fisiche robuste, possa trasformarsi in un vero tallone d’Achille, rinfocolando il dibattito sulla necessità di investire in storage, interconnessioni transfrontaliere e sistemi di controllo più intelligenti.
Accuse di “kill switch” nel fotovoltaico cinese
La transizione globale verso le energie rinnovabili ha un lato oscuro inatteso. Dietro i pannelli solari scintillanti made in China, si nasconderebbe infatti un’insidia tecnologica: un presunto “kill switch” remoto capace di spegnere interi impianti fotovoltaici occidentali a comando. L’allarme è stato lanciato da un’inchiesta internazionale, sollevando timori che Pechino possa, in caso di conflitto o forte tensione geopolitica, lasciare al buio l’Europa e gli Stati Uniti con un semplice click. Mentre la Cina domina il mercato globale del fotovoltaico, l’Occidente inizia a interrogarsi sulle possibili implicazioni di una tale dipendenza tecnologica e sui rischi nascosti che potrebbero celarsi dietro l’apparente rivoluzione verde.
La possibilità ventilata è che la Cina abbia installato segretamente nei dispositivi chiave – gli inverter che collegano i pannelli solari alla rete elettrica – componenti occultati e controllabili a distanza, capaci di interrompere all’istante la produzione di energia. Fonti dell’intelligence statunitense, citate dall’inchiesta, ipotizzano che in caso di escalation militare o crisi internazionale, Pechino potrebbe attivare questi meccanismi nascosti per spegnere in massa gli impianti fotovoltaici nei Paesi considerati ostili. In pratica, un “kill switch” – ovvero un interruttore di emergenza integrato – applicato su scala vasta agli impianti solari equivarrebbe a un’arma invisibile già installata sopra i tetti di case, aziende e infrastrutture vitali d’Occidente. Nessuna prova ufficiale è stata ancora resa pubblica a supporto di queste accuse, e dal canto suo Pechino le respinge definendole un allarmismo pretestuoso che “distorce e denigra” i successi tecnologici cinesi. Tuttavia, il solo sospetto che le infrastrutture energetiche occidentali possano essere manipolate a distanza da un fornitore straniero ha fatto scattare un serio campanello d’allarme in molti governi.
Dipendenza tecnologica e vulnerabilità geopolitica
La Cina oggi detiene una posizione dominante nella filiera del fotovoltaico mondiale: produce oltre l’80% dei pannelli solari (e degli inverter) installati nel pianeta, controllando quasi ogni anello della catena produttiva, dal silicio grezzo ai moduli finali. Ciò significa che Stati Uniti ed Europa – pur in crescita sul fronte delle installazioni domestiche – restano pesantemente dipendenti dalle forniture cinesi per alimentare la propria transizione energetica. Una tale dipendenza, in caso di attacco informatico coordinato o spegnimento remoto di massa, rischia di trasformarsi in una gravissima vulnerabilità strategica: l’ipotetico cavallo di Troia tecnologico di Pechino potrebbe colpire al cuore le reti elettriche occidentali, paralizzando intere economie in pochi istanti.
Uno scenario del genere minaccia non solo la stabilità energetica ma anche l’economia: un blocco improvviso di larga parte della generazione solare comporterebbe blackout diffusi, danni industriali e il caos nei mercati energetici. Non a caso, un recente squilibrio di rete avvenuto in Spagna – dovuto alla disconnessione improvvisa di numerosi impianti fotovoltaici – ha mostrato quanto sia cruciale disporre di infrastrutture resilienti e piani di emergenza efficaci. La posta in gioco, insomma, va oltre la semplice questione energetica: l’infrastruttura elettrica nazionale è ormai un tassello chiave della sicurezza di uno Stato moderno.
Non sorprende, quindi, che anche la NATO abbia acceso i riflettori sul problema, avvertendo che la Cina sta intensificando i propri sforzi per controllare le infrastrutture critiche dei Paesi occidentali e che “dobbiamo identificare le dipendenze strategiche e prendere provvedimenti per ridurle”. D’altra parte, con la diffusione capillare dei dispositivi solari cinesi in tutto il mondo, qualunque futura crisi geopolitica potrebbe avere ripercussioni immediate sull’approvvigionamento energetico di molti Paesi. In altre parole, l’ombra di un kill switch globale impone all’Occidente di ripensare la propria esposizione tecnologica verso Pechino, prima che la prossima tensione internazionale la trasformi in arma di ricatto su vasta scala.
Allarme e diffidenza negli Stati Uniti
La diffidenza crescente di Washington verso la tecnologia cinese è alimentata da riscontri concreti. Negli ultimi mesi, esperti americani di cybersecurity hanno smontato varie apparecchiature importate scoprendo moduli di comunicazione “fantasma” nascosti dentro alcuni inverter solari e batterie prodotti in Cina – componenti non dichiarati nelle specifiche ufficiali. Questi dispositivi segreti, ad esempio piccole radio cellulari camuffate nelle apparecchiature, possono aprire canali di accesso remoto secondari capaci di bypassare i firewall installati dalle utility e di inviare comandi a insaputa dei gestori. La rivelazione ha innescato un immediato dibattito politico: al Congresso, diversi parlamentari hanno chiesto una revisione a tappeto dei dispositivi fotovoltaici importati dalla Cina, mentre il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha avviato verifiche su impianti ritenuti “critici” per la rete nazionale.
La strategia americana in risposta alla minaccia percepita è duplice: da un lato colpire le importazioni cinesi, dall’altro rafforzare la produzione interna. Già da alcuni anni Washington ha imposto dazi e restrizioni sui componenti fotovoltaici made in China e, con l’Inflation Reduction Act, ha stanziato miliardi per stimolare una filiera solare nazionale. La cinese Huawei – leader mondiale degli inverter con circa il 29% delle consegne globali – è stata di fatto estromessa dal mercato USA a partire dal 2019, anno in cui furono messi al bando i suoi apparati 5G, e tuttora la sua tecnologia rimane esclusa per motivi di sicurezza nazionale. Più di recente, due senatori hanno proposto di vietare entro il 2027 l’acquisto governativo di batterie al litio prodotte da aziende cinesi ritenute vicine a Pechino – un segnale evidente della volontà politica di decoupling tecnologico. Parallelamente, alcune grandi utility energetiche statunitensi hanno iniziato a sostituire inverter cinesi con alternative di altri Paesi, in via precauzionale, nonostante i costi maggiori. Il messaggio che arriva da Washington è chiaro: “la minaccia del Partito Comunista Cinese è reale e in crescita” ha dichiarato un membro del Congresso, sottolineando che Pechino “non si fermerà davanti a nulla” pur di prendere di mira le infrastrutture sensibili d’Oltreoceano.
Scenari futuri per l’Europa: indipendenza energetica e tecnologica
Anche in Europa la questione sta emergendo in tutta la sua urgenza. Il vecchio Continente dipende fortemente dal fotovoltaico cinese per centrare i propri obiettivi di transizione ecologica, avendo incrementato le importazioni di pannelli asiatici soprattutto in seguito alla crisi energetica degli ultimi anni. Si calcola che oltre 200 GW di capacità solare in Europa – pari a più di 200 centrali nucleari – siano legati a inverter prodotti in Cina. Comprensibilmente, dunque, l’ipotesi di un kill switch azionabile da remoto inquieta anche le istituzioni europee. Bruxelles, per ora, non ha imposto restrizioni severe come quelle statunitensi, ma la Commissione UE sta riesaminando le normative sulla sicurezza delle infrastrutture critiche; alcuni Stati membri hanno sollevato dubbi sull’uso di tecnologia cinese nei settori sensibili e si discute di definire standard comuni per valutare l’affidabilità dei componenti e incentivare una produzione europea autonoma. Paesi come la Lituania intanto si sono portati avanti: Vilnius ha approvato una legge che vieta l’accesso remoto agli impianti rinnovabili di potenza elevata da parte di aziende di Stati considerati ostili (in primis la Cina), mentre i servizi d’intelligence estoni avvertono che senza misure analoghe persino la sicurezza nazionale potrebbe essere oggetto di potenziali ricatti geopolitici da parte di Pechino.
Per ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi, l’Europa sta valutando sia soluzioni industriali sia tecnologiche. Accanto al dibattito politico sulle possibili diversificazioni dei fornitori e sul potenziamento della capacità produttiva interna, c’è fermento sul fronte dell’innovazione: aziende europee (affiancate da realtà statunitensi e sudcoreane) stanno investendo in nuove generazioni di pannelli solari, come quelli alla perovskite o i moduli “tandem” che combinano silicio e perovskite, con l’obiettivo di superare le prestazioni dei prodotti tradizionali cinesi. Queste tecnologie emergenti potrebbero in futuro offrire alternative più sicure e competitive, mitigando il dominio asiatico sul mercato fotovoltaico. La sfida, tuttavia, sarà conciliare sicurezza e sostenibilità economica: i pannelli cinesi hanno trionfato finora grazie a costi inferiori (produzione su larga scala, manodopera a basso costo, forte supporto statale), mentre quelli europei risultano generalmente più costosi ma offrono maggiori garanzie di trasparenza, tracciabilità e sicurezza tecnologica.
In definitiva, l’“ombra” che aleggia sul fotovoltaico cinese sta costringendo l’Occidente a ripensare le proprie strategie energetiche e tecnologiche. I prossimi anni diranno se Europa e America sapranno emanciparsi dalla dipendenza attuale, costruendo filiere rinnovabili più autonome e sicure, oppure se continueranno a camminare sul filo sottile di una vulnerabilità geopolitica potenzialmente esplosiva. Le implicazioni tecnologiche e strategiche in gioco suggeriscono che l’indipendenza energetica potrebbe presto diventare importante tanto quanto la transizione verde stessa – perché il sole, per illuminare davvero il futuro, dovrà splendere senza ombre di ricatto.
La “via solare” italiana, tra orgoglio e vulnerabilità
In casa nostra il sole brilla già forte: nel 2024 il fotovoltaico ha coperto il 14 % della generazione elettrica nazionale, contribuendo a far salire le rinnovabili al 41,2 % dei consumi di corrente – record storico per l’Italia. E il Piano Nazionale Energia-Clima promette di spingere la potenza installata fino a 80 GW entro il 2030, quasi il doppio di oggi. Ma c’è un rovescio della medaglia: il 95 % dei pannelli che montiamo arriva da fabbriche cinesi, e con loro l’inevitabile corredo di firmware opachi, moduli d’inverter dal passaporto ignoto e – chissà – qualche “chiavetta” remota dormiente.
L’Italia, cantore del “Made in” per eccellenza, rischia così di trovarsi col cuore energetico in outsourcing: se Pechino starnutisce o decide di tirare un filo digitale, il nostro sistema può bloccarsi in un attimo.
E mentre Roma litiga ancora su dove piazzare (o vietare) i pannelli nei campi agricoli – rischiando di rallentare di altri otto anni gli obiettivi verdi – la Cina sforna moduli a prezzi stracciati e consolida il proprio monopolio tecnologico. È il paradosso del Bel Paese: ambire all’indipendenza ecologica comprando componenti da chi potrebbe chiuderci il rubinetto con un soft-reset.
Che fare, dunque? Servono tre mosse, e servono adesso:
- Filiera nazionale “dal silicio alla nuvola”. Incentivi mirati a wafer, inverter e software di controllo sviluppati in Italia – non per autarchia nostalgica, ma per trasparenza e presidio industriale.
- Cyber-salvagente obbligatorio. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dovrebbe imporre test di penetrazione e certificazioni a tutti i dispositivi connessi alla rete;
- Rete intelligente e accumuli diffusi. Più storage, più interconnessioni e più algoritmi predittivi: così un’improvvisa nube (o un oscuro kill switch) non diventa l’innesco di un domino alla spagnola.
In sintesi, il fotovoltaico resta la nostra strada maestra, ma solo un’Italia che padroneggia la propria tecnologia potrà godere davvero del proprio sole. Abbiamo inventato la pila, il microchip Olivetti e perfino la moka: non vorremo mica lasciare che l’interruttore lo tenga qualcun altro in tasca?