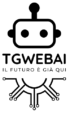L’intelligenza artificiale non è più un orizzonte lontano: è una realtà che permea ogni settore della società. Dalla sanità all’istruzione, dalla finanza alla pubblica amministrazione, l’IA ridefinisce processi, competenze e rapporti di potere. Eppure, il dibattito giuridico su come regolamentarla resta ancora in fase embrionale. In questo contesto si inserisce un’iniziativa fondamentale: la nascita dell’Osservatorio sul Diritto all’Innovazione, promosso dalla Fondazione Einaudi e presentato in Senato nella Sala Nassirya.
Un progetto ambizioso, presieduto dal costituzionalista Giovanni Guzzetta, che punta a colmare un vuoto culturale e normativo. “Serve un approccio equilibrato, laico, pragmatico. Niente isterismi apocalittici, ma nemmeno cieca adesione tecnocratica,” spiega il giurista. L’obiettivo è chiaro: contribuire a una disciplina giuridica capace di valorizzare l’innovazione senza sacrificare i diritti fondamentali.
Il diritto all’innovazione esiste?
L’espressione “diritto all’innovazione” suona, a una prima lettura, come un ossimoro. Il diritto regola, l’innovazione scardina. Eppure, la coesistenza non solo è possibile, ma necessaria. L’Osservatorio propone di legittimare l’innovazione come spazio giuridico proprio, con diritti da promuovere (come l’accesso all’identità e all’istruzione digitale) e diritti da tutelare (privacy, autodeterminazione, trasparenza degli algoritmi).
Questa visione impone un salto culturale. Le costituzioni novecentesche sono state scritte per un mondo analogico: l’habeas corpus tutelava il corpo fisico, oggi serve un habeas data che protegga la nostra identità digitale. In questo senso, l’innovazione non è solo un diritto in sé, ma anche una chiave per reinterpretare i diritti esistenti alla luce dell’era digitale.
Oltre la paura: verso una regolazione intelligente
Finora, il paradigma dominante ha privilegiato la cautela: il GDPR, l’AI Act, le raccomandazioni etiche UE. Tutti strumenti legittimi, ma spesso nati sulla difensiva, più per contenere che per guidare. Come osserva Guzzetta, il rischio è che “gli oneri regolatori finiscano per soffocare lo sviluppo, come ha denunciato anche il rapporto Draghi”.
La sfida è dunque duplice: regolare senza frenare, tutelare senza paralizzare. Un compito che richiede non solo nuove norme, ma nuove categorie giuridiche. Che cos’è, ad esempio, la responsabilità in un sistema decisionale algoritmico? Chi risponde quando un’intelligenza artificiale discrimina, sbaglia, danneggia?
Il diritto come infrastruttura dell’innovazione
Il diritto all’innovazione non va confuso con una deregolamentazione selvaggia. Al contrario: serve più diritto, ma di qualità. Un diritto che funzioni come infrastruttura abilitante, come binario sicuro su cui far correre il treno dell’innovazione.
Questo è l’obiettivo dell’Osservatorio: promuovere un diritto che non rincorra la tecnologia, ma la affianchi. Che sappia anticipare scenari, proporre soluzioni, favorire un’innovazione inclusiva, equa, sostenibile. Un diritto che riconosca che l’accesso alle tecnologie digitali non è più un privilegio, ma una condizione di cittadinanza attiva.
Un’agenda concreta per il cambiamento
Non si parte da zero. Come ricorda Guzzetta, esistono già strumenti legislativi in corso d’opera, a partire dal ddl Concorrenza ora in discussione al Senato. Inserire in quel contesto una riflessione sull’IA e sull’accesso equo alle tecnologie può rappresentare un primo passo per radicare il diritto all’innovazione nel cuore della politica economica nazionale.
Il vero banco di prova sarà però la capacità dell’Osservatorio di incidere sul lungo periodo, proponendo un nuovo costituzionalismo digitale che non si limiti a tamponare le criticità emergenti, ma disegni un futuro dove l’innovazione sia diritto di tutti, non privilegio di pochi.